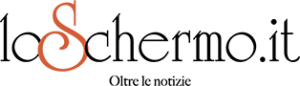Tema ambizioso! L’otium agostano, distaccandomi dalle incombenze professionali quotidiane, deve avermi reso filosofico. E così mi son trovato a riflettere su un argomento grande, quasi “impossibile”. Cerco di mettervene a parte.
In greco antico, per dire “felicità” si usava il termine ευδαιμονία (eudaimonía), parola composta dall’avverbio ευ (eu), che significava “bene”, e dal sostantivo δαίμων (dàimon), che voleva dire sia “dio” / “divinità”, sia “sorte” / “destino” / “caso”, sia, infine, “spirito” / “genio” (cioè “personificazione di una passione, positiva o negativa, che agiti il cuore dell’uomo”), ovvero “dèmone” (nel senso, però, di “entità intermedia tra il divino e l’umano”, non di “diavoletto”!). Etimologicamente, dunque, l’eudaimonía poteva designare per un verso una situazione materiale in cui le divinità fossero propizie, garantendo così prosperità, agiatezza, benessere e buona salute (e questo era, credo, il significato più comune, essendo afferente a dati concreti, esteriori, quindi facilmente riscontrabili), per l’altro, invece, una favorevole condizione dello spirito, cioè uno stato di serena tranquillità, privo di irrequietudini e affanni, nel quale – per l’assenza di rimorsi o di desideri smodati e al di fuori della nostra portata – si è in pace con se stessi, appagati dal proprio rapporto con sé e con il prossimo.
Molti ricorderanno che Socrate affermava che un dèmone gli si manifestasse interiormente come una voce che lo distoglieva dal commettere ingiustizie ed errori morali: con questo termine egli si riferiva alla coscienza morale, intesa come personale assunzione di responsabilità, e non come passiva adesione formale a norme esteriori. Secondo lui, seguendo le direttive del proprio dèmone individuale si poteva essere felici, poiché la virtù e la felicità erano per Socrate strettamente correlate, come le due facce di una stessa medaglia. La sua, cioè, era una dottrina eudemonista: essendo la felicità alla portata dell’uomo, era dovere di ognuno tentare di conquistarla, e il mezzo migliore per farlo era, appunto, agire secondo la virtù.
In effetti, è impossibile essere felici se non si ha la coscienza a posto (per carità, qualcuno ci riesce, ma…); certo, l’assenza di rimorsi non è sufficiente, di per sé, a garantire la felicità, ma ne è, comunque, una conditio sine qua non. In realtà, definire la felicità è impossibile, se non in termini negativi, ovvero dicendo che cosa essa non sia, o in quali condizioni non possa sussistere: per esempio, il dolore fisico e psicologico, la noia, l’eccessiva ambizione etc. sono tutti fattori in cui presenza non si può essere felici.
Bisogna stabilire, poi, se la felicità sia un fatto puramente individuale, o se invece possa essere considerata anche in termini collettivi: in parole diverse, la politica può contribuire alla felicità dell’uomo? Certo, è innegabile che alcuni periodi storici siano stati più travagliati: nei tempi di guerra, carestia e pestilenza, credo fosse difficile essere felici, visto che la propria vita era continuamente in pericolo e in balìa degli eventi. D’altronde, anche l’epoca presente, che pure – benché con le troppo numerose e note eccezioni, alcune delle quali vicine – è nel complesso pacifica e prospera rispetto alla gran parte delle precedenti, non può dirsi felice, perché l’eclissi del senso morale, il tramonto della nostra civiltà e cultura europee, il diffuso clima di disagio e insoddisfazione prodotto dall’allentamento e dalla banalizzazione dei legami sociali (e sovente familiari) rendono più arduo il conseguimento della felicità individuale e collettiva. Quindi, anche le condizioni politiche e sociali possono influire sulla determinazione della felicità.
È malagevole dire se e quando si è stati felici, innanzi tutto perché, se davvero lo siamo stati, spesso ce ne siamo accorti soltanto dopo, cioè quando quella condizione beata è venuta meno. È invece semplice dire se e quando siamo stati infelici, perché è più facile avvertire e definire il dolore e lo sconforto. Personalmente, sono portato a ritenere che la Felicità, nel senso completo del termine, sia raggiungibile soltanto in prospettiva trascendente, e che durante la nostra vita terrena noi possiamo al massimo godere di una sua pallida prefigurazione.
Se invece lasciamo perdere la Felicità e vogliamo piuttosto discorrere, più modestamente, delle felicità, cioè di quell’effimero sentimento di indefinibile piacere che di tanto in tanto si impadronisce della nostra anima, non riesco a pensare che a piccole e banalissime situazioni quotidiane: trascorrere una gradevole serata tra amici, ottenere un successo professionale, rincantucciarsi in una sera d’autunno accanto al caminetto, tornare a casa dopo una giornata faticosa e trovare il conforto degli affetti familiari, veder ridere i bambini (salvo mutare improvvisamente d’umore se ti rompono un soprammobile o ti scarabocchiano un libro), giocare con il proprio gatto, assaporare una pietanza squisita, ammirare il cielo cristallino di certe mattinate di gennaio: tutto ciò, insomma, che ha a che fare con la serenità e la soddisfazione.
E poi esiste quel meraviglioso strumento di beatitudine, ascesi e dimenticanza di sé che è l’arte, la creazione umana che più si avvicina al divino, al totalmente altro (ganz Anderes), per usare un’espressione teologica.
Paolo Bolpagni