Nel dibattito pubblico italiano, pochi argomenti sono carichi di emotività e incomprensione quanto quello delle pensioni. Al centro di questo malinteso c’è un termine che usiamo quotidianamente: “contributi previdenziali”. Lo percepiamo come un risparmio forzato, un “accantonamento” personale che mettiamo via oggi per goderne domani.
Questa percezione è, nella migliore delle ipotesi, una finzione contabile; nella peggiore, è la radice di un dibattito viziato che impedisce riforme eque e sostenibili.
La tesi di questo articolo è semplice: i contributi previdenziali, nel sistema italiano, non sono accantonamenti, ma tasse a tutti gli effetti. E chiamarli con il loro nome è il primo, indispensabile passo per capire i veri problemi che abbiamo di fronte.
Il Meccanismo: Pagare un Servizio, non Riempire un Salvadanaio
Il sistema pensionistico italiano è un sistema “a ripartizione”, non “a capitalizzazione”. La differenza è abissale:
- Sistema a Capitalizzazione (il salvadanaio): Ogni lavoratore versa i suoi contributi in un fondo personale (come è invece il caso di un fondo pensione privato). Questi soldi vengono investiti e crescono nel tempo. La pensione futura dipenderà esclusivamente da quanto si è versato e da come sono andati gli investimenti. Questo è un accantonamento.
- Sistema a Ripartizione (quello italiano): I contributi versati oggi da chi lavora (la “massa raccolta”) non vengono messi da parte. Vengono usati immediatamente per pagare le pensioni di chi è già in quiescenza.Non c’è alcun legame effettivo tra quanto uno versa e quanto percepirà. Questo è un servizio pubblico.
Quando un lavoratore italiano paga i contributi, non sta mettendo fieno in cascina per la sua vecchiaia. Sta pagando un servizio: il mantenimento dei pensionati attuali. È, a tutti gli effetti, un’imposta di scopo: una tassa sul reddito destinata a finanziare una specifica (e massiccia) voce di spesa pubblica. In effetti una voce che, da sola, vale quasi la metà del budget dello stato e circa 4 volte l’intera spesa sanitaria.
La Sconnessione: Diritti Acquisiti e Privilegi Consolidati
Questa natura fiscale del sistema genera due distorsioni che alimentano il conflitto generazionale e impediscono un dibattito serio e razionale.
La prima è la totale assenza di pertinenza tra quanto versato e quanto percepito. Moltissimi degli attuali pensionati percepiscono assegni (calcolati con il generoso metodo “retributivo”) che non sono neppure vagamente collegati con i contributi che hanno versato decenni fa, quando le aliquote erano diverse e le carriere spesso più brevi. Semplicemente sono riferiti allo stipendio percepito prima di andare in pensione. E, frequentemente, soprattutto per i lavoratori pubblici, sono viziate dall’uso di concedere promozioni di carriera alla fine della stessa allo scopo di garantire una pensione più alta. È il caso, ad esempio, delle Forze Armate (ma, similmente, anche di Carabinieri, Finanza, Polizia, Vigili del Fuoco ecc.) dove moltissimi ufficiali ricevevano la promozione a generale pochi mesi prima dalla pensione: una promozione che non ha senso dal punto di vista organizzativo od operativo ma si motiva in questo modo.
La seconda distorsione riguarda il futuro. La pensione che percepirà chi lavora oggi non dipende da quanto sta versando, ma da una variabile totalmente fuori dal suo controllo: quanti lavoratori ci saranno tra 30 o 40 anni e quale sarà la loro capacità di pagare contributi (la “massa raccolta” futura che dovrà essere divisa tra chi sarà in pensione).
È qui che l’idea del “diritto acquisito” basato sul “versato” mostra la sua fallacia e nasconde un profondo egoismo generazionale. Quello che si può definire veramente un tradimento del patto generazionale.
Quando un pensionato (o un lavoratore vicino alla pensione) difende i suoi “diritti acquisiti” basati su regole di calcolo generose, sta di fatto difendendo un privilegio consolidato. Non sta reclamando i suoi soldi accantonati (perché non esistono), ma sta esigendo che lo Stato tassi le generazioni future (i lavoratori attuali) per onorare una attesa maturata in un contesto demografico ed economico che non esiste più.
Si tratta di un trasferimento di ricchezza dai giovani (pochi e spesso precari) ai pensionati (molti e con assegni spesso superiori ai salari medi di chi queste tasse le sta pagando), mascherato dalla retorica del “ho pagato per 40 anni”.
La Chiarezza Perduta: perché chiamarle “Tasse” aiuta
Se smettessimo di parlare di “contributi” e iniziassimo a chiamarla “tassa per le pensioni”, il dibattito cambierebbe radicalmente.
Questa chiarezza terminologica aiuterebbe a capire i limiti di bilancio invalicabili. Se i contributi sono tasse, allora il sistema pensionistico è una voce di spesa pubblica, la più grande del bilancio statale. Come per la sanità o l’istruzione, questa spesa deve essere sostenibile rispetto a quanto si incassa.
Smontare la finzione dell'”accantonamento” (che non c’è) renderebbe evidente a tutti che le pensioni non sono un diritto divino slegato dalla realtà economica, ma una scelta di politica fiscale.
Oggi, ogni proposta di riforma (come l’adeguamento all’aspettativa di vita o il ricalcolo contributivo) viene vissuta come un “furto” dei risparmi dei lavoratori. Se fosse limpido che risparmi non ce ne sono e che si tratta di rimodulare una tassa e la relativa spesa pubblica (per evitarne il collasso), la discussione si sposterebbe su dati di fatto: la demografia.
Il rapporto tra lavoratori attivi (che pagano le “tasse-pensioni”) e pensionati (che ricevono il “servizio”) sta crollando. Meno lavoratori devono sostenere più pensionati per più tempo. Se ci fosse un salvadanaio per ciascuno forse non sarebbe un problema. Ma di salvadanai non ce ne sono; c’è solo un sistema fiscale che può pagare queste pensioni, ma solo aumentando le aliquote a livelli insostenibili; alternativamente si sostiene tagliando le prestazioni. O, come ultima alternativa, lavorando più a lungo per diluire il costo e aumentare la massa di lavoratori.
Accettare che i contributi sono tasse ci costringe a guardare in faccia la realtà: il patto intergenerazionale su cui si fondava la ripartizione si è rotto. Continuare a negarlo, nascondendosi dietro la foglia di fico dei “contributi versati”, significa solo scaricare il costo di quei privilegi consolidati su chi non può più sostenerli. E innescare una bomba ad orologeria che esploderà con conseguenze imprevedibili e feroci.
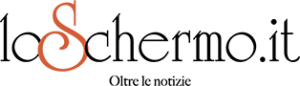
Le cose stanno precisamente così. Non si può argomentare meglio.
In effetti l’articolo è perfetto e descrive in maniera eccellente la vera realtà pensionistica. Per il futuro la situazione è incerta e problematica: i giovani attuali non sanno se potranno godere della pensione e in quale misura, ma sicuramente saranno molto penalizzati. Il problema principale resta la scarsa natalità che da anni interessa i Paesi più avanzati e , soprattutto il nostro. Anche l’immigrazione contribuirà poco, in quanto si tende a generare sempre meno figli a causa della situazione economica complicata e del futuro incerto sotto vari punti di vista, guerre, inquinamento del pianeta ecc. Speriamo che il sistema regga!!!!
Articolo perfetto.
Simulazioni di una mia pensione futura parlando di 300-350 euro al mese per 12 mesi (molto al di sotto della pensione minima sociale). Per arrivare ad una pensione dignitosa (farei la firma per 900-1000 euro al mese!!!!!!!!) dovrei fatturare una quantità tale che è semplicemente impossibile.