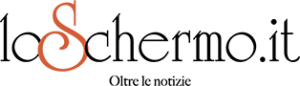Ci siamo, siamo ormai prossimi al voto per il referendum. Il nostro voto annuale che non ci manca mai…
Come andrà?
Se fosse un giallo sarebbe come chiedersi se leggere l’ultima pagina del libro. Cionondimeno la risposta appare probabilmente scontata: pochi, anche tra i promotori, credono che il quorum verrà raggiunto.
Eppure, al di là del risultato, appare importante fare una riflessione sulla proposta e su quanto vi si muove attorno.
Prima di tutto: era necessario questo referendum?
Più precisamente questi referendum? Perché i referendum in proposta sono 5.
Nell’ordine:
- Referendum sulla reintroduzione della facoltà, per il giudice, di disporre il reintegro in azienda per i casi di licenziamento illegittimo.
- Referendum sulla eliminazione dei limiti di indennizzo per le piccole imprese fino a 15 dipendenti, sempre per i casi di licenziamento illegittimo
- Referendum sul ripristino dell’obbligo delle causali per i contratti a termine
- Referendum per l’introduzione della responsabilità “in solido” dell’appaltatore con le imprese appaltanti e subappaltanti in materia di sicurezza del lavoro
- Referendum sul dimezzamento (da 10 a 5 anni) del periodo di residenza in Italia per poter avere la cittadinanza
Come si vede, il grosso delle proposte è sul tema del lavoro.
Se andiamo a vedere i dati non pare che questi referendum siano concentrati su tematiche caratterizzate da urgenza di intervento: tutti gli indicatori dicono che il mercato del lavoro è in uno stato di salute abbastanza buono e comunque migliore che in passato. in altre parole, il vituperato jab-act non ha peggiorato il mercato del lavoro. Anzi, guardando le serie storiche, sembra pure migliorato (naturalmente nessuno può garantire che non sarebbe migliorato anche senza il job-act ma “con i se e con i ma la storia non si fa”). E particolarmente, non lo ha peggiorato nelle dimensioni oggetto dei referendum.
I dati del mondo del lavoro, infatti, parlano di una diminuzione dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo determinato. Questo sia valutato nel breve periodo che nel lungo. In entrambi gli scenari infatti i contratti a tempo determinato sono tra stabili o in contrazione mentre aumentano quelli a tempo indeterminato. Effetto opposto da quanto paventato dai detrattori del job-act ai tempi della sua approvazione. Questo dato (del numero di contratti) in linea con quello che vede oggi in Italia il massimo livello di occupati registrato dal 1977. Con un unico dato peggiore di una volta: gli inattivi giovani (cioè con un’età tra i 15 e i 24 anni).
Quest’ultimo fenomeno, però, difficilmente può essere giustificato con gli effetti delle discipline che si vogliono rimuovere. Fra l’altro non sono certo mancati sostegni dello Stato all’impiego di giovani (in questo si è trattato di interventi bipartisan: sia dai governi di sinistra che dall’attuale). Piuttosto questo fenomeno, che ha un senso rilevante per il valore si attribuisce al lavoro, è da vedersi come causa e, al tempo stesso, effetto di una discendente qualità della dimensione lavorativa nella vita: il mondo del lavoro sta perdendo il significato di una parte essenziale dell’esperienza umana per essere delegato sempre più a dimensione frustrante e dequalificante della quotidianità in opposizione al benessere della vita extra-lavorativa. Ma questo esula di molto dalla riflessione sul referendum.
I dati dicono anche che le cause per licenziamento illegittimo sono calate (anche se non di molto) dopo l’entrata in vigore del job-act. Il che significa che non solo non c’è stata l’esplosione di licenziamenti illegittimi che giustificherebbe la richiesta abrogazione, ma il problema dei licenziamenti illegittimi si è pure ridotto (la normativa attuale pone solo il limite nel non reintegro, non nella richiesta di risarcimento).
I primi tre referendum, quindi, a parte la sensibilità nostrana sul diritto al lavoro, non hanno una base di necessità riscontrabile nei numeri e negli andamenti del mercato del lavoro.
Il quarto quisito è più delicato: introduce un obbligo per il committente di controllare la catena di appalto sui temi di sicurezza essendo quest’ultimo responsabile “in solido” in caso di incidenti sul lavoro.
Su questo tema, a mio avviso, siamo decisamente in un campo di demagogia. È facile dire che sulla sicurezza non si deve scherzare, che tutto deve essere corretto. E, in astratto, è anche giusto. Ma da qui a dire che questi controlli e questa responsabilità debba ricadere su chi acquista un servizio ne corre. E introduce un tema di responsabilità indistinta che è contrario ad ogni ratio. Spesso vediamo queste norme come astratte e riferite ad altri: le grandi aziende che sono dei super-committenti che possono far valere uffici interni super-competenti su una pletora di subappaltatori senza scrupoli.
La realtà è che si applicano a tutti. È come dire che, se un condominio rifà la facciata e un ponteggio non è perfettamente a norma, o un operaio non indossa il caschetto, e gli casca un oggetto in testa e resta invalido tutta la vita, il responsabile (economicamente e penalmente parlando) di questa tragedia non è solo l’azienda che gestisce i lavori ma anche ogni condomino del condominio. Che può essere chiamato dagli eredi a risarcire gli ingenti costi di una causa di lavoro (dove magari la ditta ha dichiarato fallimento per questo). Quanti di voi si sentirebbero sicuri ad affidare a chicchessia un lavoro di appalto?
Il punto è che a controllare non deve e non può essere il cittadino acquirente ma lo stato con i suoi ispettorati. Le responsabilità devono essere riportate a controlli che un individuo (sia esso un semplice cittadino o una multinazionale) possa ragionevolmente fare, non estesi a piacere come un elastico. Diverso è rendere obbligatorio che negli appalti siano evidenziate le spese per la sicurezza (cosa che è già obbligo) e diverso è prevedere una sorta di responsabilità diffusa, quasi contagiosa, che immobilizza tutto.
In effetti questo è un tema che, con le dovute differenze riguarda tutta la logica perversa dietro questi referendum (eccetto l’ultimo). L’idea che si possano aggiungere vincoli e responsabilità senza che se ne paghi un effetto di limitazione di benessere complessivo. Assumere un dipendente è come prendersi un rischio: un imprenditore fa un pensiero non dissimile da quello che fa chi apre un mutuo. Se prendo un tasso fisso senza possibilità di riscatto lo farò solo se sono davvero convinto che i tassi non scenderanno. Altrimenti voglio un tasso variabile. O magari non ne faccio di nulla. Così pure l’imprenditore: se deve assumere si deve prendere un rischio. Se non può licenziare o se non può valutare quanto gli potrebbe costare uscire da una situazione che non funziona, lo farà solo se è molto sicuro del bisogno. E le assunzioni a tempo indeterminato saranno meno, favorendo le forme più flessibili come i tempi determinati. Se invece ha la possibilità di uscire da un contratto in un modo prevedibile sarà più propenso ad assumere. E lo farà con tanta maggiore facilità quanto meno è il prezzo di un errore di valutazione. Il che produrrà maggiori assunzioni.
Possiamo naturalmente osservare che il limite di questo ragionamento è che, oltre un certo segno, la flessibilità può diventare uno strumento di coercizione. Ma, indubbiamente, oggi in Italia abbiamo uno dei sistemi meno flessibili di tutto il mondo occidentale. Non pare davvero che ci sia necessità di aumentare la rigidità del mercato del lavoro.
L’ultimo tema referendario è forse l’unico che potrebbe essere giustificabile.
Spiace osservare che nessuna delle organizzazioni promotrici del sì ci spenda sopra neppure una parola…