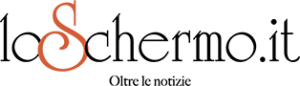Tornano, dopo circa mezzo secolo, nella processione di Santa Croce i “Cristezzanti”, figure storiche e portatori di crocifissi nelle processioni liguri, organizzati in confraternite. Si tratta di una tradizione molto radicata in Liguria, già presente a Lucca per diversi anni nel secondo scorso nella processione della luminara del 13 settembre. Una tradizione amata dal popolo ligure, specie quello di Levante. I grandi crocifissi processionali portati dai “stramuri”, ovvero dai portatori che con la sola forza delle braccia e lavorando grazie ad una tecnica che governa il crocco in movimento e con passaggi precisi e rapidi riescono in pochi secondi a farli passare da un portatore all’altro. Crocifissi che pesano anche 150 chili l’uno. A Lucca sabato prossimo saranno in processione tre di questi crocifissi: uno da 135 chili, uno da 85 chili e uno da 30 chili circa.
Una presenza che è frutto degli stretti rapporti fra il presidente della Confraternita di San Giacomo Apostolo di Levanto, Giovanni Gianelli, e l’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti. Proprio ieri mattina sono stati definiti gli ultimi dettagli che porteranno a Lucca circa quaranta confratelli di tre confraternite liguri.
La tradizione ligure sembra nata nel XIII secolo quando i flagellanti, in cappa bianca nelle processioni penitenziali, partivano da Montecarlo e arrivavano a Roma, pregando e cantando con grande devozione. Il movimento fece breccia a Genova e in Liguria da lì si innescò un processo di emulazione che a cavallo del XVI e XVII, anche dietro l’influenza spagnola, ebbe un grande sviluppo tanto che subito nacque una scuola di sculture il cui primo maestro fu Bissoni e, dopo, di lui Anton Maria Maragliano. Non si può fare altro che definirle opere d’arte di una bellezza sconvolgente.

«Quello dei Cristi processionali liguri – spiegano i confratelli – è un mondo che non deve rimanere chiuso dentro le chiese, gli oratori o i conventi perché sono interpreti di fatti devozionali che hanno tracciato, anche attraverso i percorsi iniziali delle confraternite, i messaggi più belli del Vangelo. Papa Francesco, vedendoli sfilare a San Pietro si è emozionato, ricordandosi di averli visti in Argentina a Rosario e Arrojo Seco, dove i genovesi emigrati abbondano, quando da arcivescovo di Buenos Aires visitò quelle città. Quest’arte è frutto di un periodo fiorente: gli autori di questi capolavori hanno rappresentato la religione in modo eccezionale con il volto e il corpo di Cristo di tale intensità espressiva da lasciarci sempre sconvolti».

Cristezzanti è la definizione antica di questa realtà di uomini di fede. Nei secoli passati, le confraternite ebbero un ruolo primario nel sostegno dei più deboli e nelle difficoltà della quotidianità del popolo, oggi espressa anche nella grande partecipazione della cittadinanza agli eventi e alle liturgie legate all’ostensione di casse processionarie e grandi crocefissi in legno.
«In origine – spiegano alla Confraternita di San Giacomo Apostolo di Levanto – le Casacce furono confraternite di flagellanti o disciplinanti, devoti che si riunivano per fare insieme penitenza dei peccati loro battendosi le spalle e la schiena nuda colla disciplina, e questa consisteva di un manico di legno cui erano attaccate alcune cordicelle con nodi o pallette di ferro, o anche spine o pezzi di metallo. Si dissero Casacce perché si riunivano in casupole dirupate, forse per risparmio di fitto, forse perché dapprincipio non erano veduti di buon occhio quegli atti un poco lesivi della incolumità personale: anche a Firenze dopo le processioni all’aria aperta i flagellanti o battuti dovettero rifugiarsi nelle cripte delle chiese e in buche sotterranee.
Nel 1399 un altro grande movimento confraternale arrivò a Genova, erano i Bianchi di Provenza, entrarono in città il 5 luglio tutti vestiti di tela bianca a sacco; anche loro imploravano misericordia e pace, le processioni erano aperte dai confratelli che portavano il Crocifisso. I disciplinanti a Genova prima si unirono al corteo, poi vestirono anch’essi il sacco col cappuccio, denudarono le schiene per continuare la flagellazione. Le Casacce erano solite uscire così tutte insieme la notte del Giovedì Santo per recarsi in processione in San Lorenzo per venerare il Sepolcro (oggi altare della Reposizione), poiché da sempre particolarmente inclini a commemorare la Passione di Nostro Signore».

Nella seconda metà del secolo XVI l’antica semplicità comincia a sparire. Gli arcivescovi di Genova nelle costituzioni che emanano nelle sinodi diocesane permettono ai fedeli d’andar in processione a due a due senza clamori cantando inni e preghiere, purché in latino, e flagellandosi con vera pietà, ma vietano di disciplinarsi a pagamento per guadagno e per conto altrui, e di riunirsi a banchetto negli oratori. La Repubblica promulga una speciale ordinanza nel 1602 per proibire molti abusi, e prescrive in essa che le vesti siano bianche di tela e semplici senza pieghe ne tasche ne bottoni né fodere di seta, cinte di semplice corda, salvo per quelli che avranno la cintura di cuoio e il crocco o bossolo per appoggiare il crocifisso: non corone al collo, né pizzetti alle camicie, né guanti, non calze di seta né stivaletti, ma solo certi calzari di cuoio, detti spardegne e affini ai sandali. Si vieta altresì che i devoti portino armi o si facciano accompagnare da paggi, servi, o bravi che diano sostegno alle frequenti zuffe e disordini che potevano verificarsi in occasione delle processioni. Inoltre alla fine del ‘600 o verso l’inizio del ‘700 vengono nominati dai Collegi i cinque Savi sulle Casacce affinché vigilino sulle confraternite perché osservino i regolamenti, specialmente in occasione della processione del Giovedì Santo.

La gara di lusso fra le varie Casacce è vivissima: i giovani gareggiano nel peso dei crocefissi e taluno paga grosse somme per esser ammesso a tale onore oneroso, anche senza esser membro di alcuna Casaccia: specialmente le tre che prendono il nome da S. Giacomo (quella di S. Giacomo e Leonardo di Prè, quella di San Giacomo delle Fucine di Portoria, quella di S. Giacomo della Marina), sono in continua discordia, che spesso porta a zuffe durante la processione, poiché ciascuna pretende di aver sola il privilegio di celebrare le laudi di S. Giacomo il maggiore, il patrono della Spagna e vincitore dei Mori.

La processione divenne uno spettacolo così mondano che parve non più conveniente ai giorni della Passione di Gesù, e nella seconda metà del secolo XVIII fu trasportata al 3 maggio, in cui si celebra l’invenzione della Santa Croce. A Levanto i Savi sulle Casacce provvedono ogni anno a determinare le strade per le quali esse devono passare nell’andata a San Lorenzo e nel ritorno all’Oratorio ad evitare confusioni.