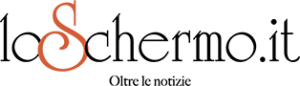Segnatevi la data: domenica 3 maggio 2026, in occasione della festa dell’Invenzione della Santa Croce ovvero del ritrovamento della croce di Cristo da parte di Sant’Elena Imperatrice. Dovrebbe essere il giorno dell’attesissimo ritorno del Volto Santo nel tempietto del Civitali all’interno della chiesa cattedrale di san Martino. Nel frattempo è atteso un volume curato da Anna Maria Giusti (consulente scientifico dell’Ente Cattedrale) con tutte le tappe del restauro, libro che è annunciato per l’inizio del 2026 dall’editore Maria Pacini Fazzi.
Sabato mattina nella chiesa di San Giovanni si è tenuto il convegno: «Il Volto Santo. Presentazione del restauro». Una nuova tappa del lungo e accurato intervento di restauro. Sono state presentate centinaia di immagini che hanno mostrato la complessità dei lavori di questi quattro anni, le sorprese e le moderne soluzioni per garantirne la prossima movimentazione, a cominciare da un’anima metallica che garantirà un sostegno adeguato all’opera che ha un peso complessivo di 152,83 chili.
Francesco Nicoli dell’Ente cattedrale, Ilaria Boncompagni funzionaria della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, Sandra Rossi coordinatrice del restauro del Volto Santo dell’Opificio delle pietre dure di Firenze, Andrea Cagnini, Ciro Castelli e Chiara De Felice hanno guidato i presenti al convegno dietro le quinte del restauro, fin dalle indagini del laboratorio scientifico dell’Opificio fiorentino. Vediamo dunque cosa è stato fatto in questi anni.
Il progetto di intervento è nato alla fine del 2021, quando la proprietà – l’Ente Cattedrale di San Martino di Lucca – ha interpellato l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (OPD) per una valutazione dello stato conservativo dell’opera, così significativa per i fedeli e simbolo stesso della città di Lucca.
Negli anni precedenti erano già state condotte alcune importanti indagini diagnostiche tra cui, nel 2020, da parte dell’INFN, il C14 su alcuni frammenti di legno, che portavano a proporre una datazione del Volto Santo al IX secolo, ora precisamente attestata, attraverso l’analisi dendrologica del legno della croce, all’860 (il margine cronologico di scostamento per questa indagine è limitato ai pochi decenni successivi alla data indicata). L’assemblaggio tra le due parti è originale e coevo. E questa è solo una delle informazioni inedite acquisite grazie all’intervento di restauro.

Il Volto Santo prima del restauro
Il settore Sculture lignee policrome dell’OPD ha pertanto elaborato il progetto di ricerca e restauro, cui ha fatto seguito, nel gennaio 2022, la stipula di una convenzione tra Ente Cattedrale, OPD, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lucca. Stante il peculiare valore dell’opera sono stati istituiti un Comitato promotore e un Comitato scientifico, con loro la Direzione Lavori ha condiviso tutte le decisioni più importanti.
Due in particolare sono state le scelte più lungamente meditate: la separazione del Cristo dalla croce e la pulitura degli strati più superficiali della pellicola pittorica, allo scopo di restituire alla scultura un aspetto più vicino a quello originario pur nella salvaguardia della sua storia articolata.
Le attività sono durate complessivamente quattro anni: due interamente dedicati alla fase conoscitiva e agli approfondimenti diagnostici (2022-2023) e due all’intervento di restauro (2024-2025).
Il Settore di restauro Sculture lignee policrome dell’OPD ha diretto e coordinato l’intervento, eseguito da Francesca Spagnoli, ma tutto l’Istituto ne è stato coinvolto: uno dei suoi punti di forza è la capacità di intervenire in maniera multidisciplinare ed interdisciplinare, con professionalità altamente specializzate in una visione integrata d’insieme, avvalendosi altresì di numerose convenzioni con Istituti di ricerca, in primis il CNR, e Università.
Il perché del restauro e i suoi risultati
Partiamo da un dato di fatto: la celebre scultura lignea necessitava di un intervento di restauro.
I sopralluoghi constatavano la presenza di uno strato di sporco superficiale distribuito in maniera non omogenea su tutta la superficie, numerosi sollevamenti della pellicola pittorica, lacune provocate da cadute di colore, segni di sofferenza del legno, sia della croce sia del Cristo, che si evidenziavano con la presenza di spaccature. Permanevano dubbi anche sulla solidità dell’aggancio tra Cristo e croce, non potendo visionare il retro per la specifica collocazione all’interno del tempietto di Civitali.
Il restauro e gli studi che l’hanno preceduto ed accompagnato nei quattro anni di cantiere hanno portato ad acquisire numerose informazioni, per quanto riguarda sia i materiali sia la tecnica esecutiva.
Abbiamo recuperato un’immagine inedita della croce, la cui prima testimonianza sinora nota risaliva agli inizi del Trecento, nella miniatura contenuta nel Codice Tucci Tognetti, in cui compare completamente azzurra. Oltre al recupero di un prezioso alfa e omega in foglia oro su fondo azzurro ciò che vediamo ora a fine restauro testimonia l’esistenza di almeno due policromie precedenti, nei toni del rosso e del blu, arricchite da motivi decorativi a fasce e a palmette.
Il Cristo ha ripreso, soprattutto nell’incarnato, l’aspetto che lo ha caratterizzato per la maggior parte della sua esistenza, dal IX al XVII secolo. Quello che ci sovrasta ora è una immagine corrusca per colori e materiali, che dobbiamo immaginare anche più ricca, dalla presenza fortissima e ipnotica, un autentico Signore della Storia.
Inoltre, nel pieno rispetto dei materiali antichi, abbiamo restituito all’insieme solidità strutturale.

Il Volto Santo dopo il restauro
Uno spostamento non semplice
La movimentazione dell’opera ha richiesto operazioni particolarmente complesse, per la posizione in cui era collocata. La croce, infatti, all’interno del tempietto di Civitali si trovava inserita per circa 70 centimetri dietro l’altare settecentesco in marmo, rendendo difficile anche solo uno studio preliminare delle sue condizioni. Si è dovuto realizzare un’apposita impalcatura e l’estrazione è avvenuta in più fasi: dopo aver velinato l’insieme, per proteggere la pellicola pittorica, la croce con il Cristo è stata sollevata, inclinata con cautela in avanti e fatta uscire lateralmente, dopo aver rimosso le grate metalliche del tempietto. In collaborazione con una ditta specializzata è stato progettato un sistema di ancoraggio su misura, che ha garantito la stabilità dell’opera durante tutte le fasi di spostamento, evitando il rischio di sbilanciamenti strutturali.
Per la ricollocazione e per rendere in futuro queste operazioni più agevoli e sicure, anche in caso di emergenza, si è quindi deciso di rinforzare la struttura, posizionando un sostegno metallico sul retro della croce e all’interno del Cristo, così da distribuire le forze in maniera omogenea e fare in modo che il corpo non gravi esclusivamente sui sei perni in legno originali (in particolare sui due posti ad altezza delle spalle). La rimozione del rivestimento ha portato in luce tracce di una antica decorazione ad affresco, fondamentale per studiare le vicende del tempietto, il cui recupero è ancora in corso.
Separazione del Cristo dalla croce e struttura di sostegno
Tra le scelte più importanti in corso di restauro, vi è stata quella di separare il Cristo dalla croce.
Il distacco è avvenuto senza alterare il sistema originario di aggancio, costituito da sei perni in legno e ha consentito di risanare la croce, laddove vi erano mancanze del legno che prima non si vedevano perché coperte dal corpo di Cristo. Ha inoltre permesso lo studio più approfondito della tecnica costruttiva della scultura, un intervento accurato sulla superficie interna dove sono presenti tracce di un vecchio attacco xilofago ed alcuni spacchi, in particolare in corrispondenza dei perni.
Fondamentale a questo riguardo è stato l’apporto del Reparto Supporti lignei del Settore dipinti su tela e tavola dell’OPD, che, insieme al Settore di restauro Sculture lignee policrome, ha anche progettato la struttura in metallo di rinforzo della croce e quella interna al Cristo.

Tipologia del legno
Il Volto Santo – comprese testa e gambe – è ricavato dall’intaglio di un unico tronco di legno di noce. La testa, molto sporgente rispetto al corpo, è intagliata nella parte del tronco verso la radice dell’albero, le gambe corrispondono alla parte del tronco rivolta alla chioma.
Il legno è svuotato sul retro in tutta la sua lunghezza e la testa è chiusa da un coperchio in legno di castagno, in passato rivestito di tessuto rosso. Probabilmente qui si collocava un antico scomparto per le reliquie.
Le braccia, anch’esse in legno di noce, sono affrancate con un incastro a tenone e mortasa.
Il corpo è unito alla croce con sei lunghi perni, due all’altezza delle spalle, due all’altezza della cintura e due in corrispondenza delle braccia. Sono in legno di quercia, tranne i due delle braccia, che sono in legno di cedro.
La croce è realizzata impiegando due specie legnose differenti: il braccio verticale è in legno di castagno, mentre quello orizzontale è in abete bianco.
Tecnica costruttiva
Grazie alla campagna diagnostica e al distacco del Cristo dalla croce, sono emersi importanti particolari tecnici e si è potuta definire la tipologia di strumenti usati nella bottega altomedievale.
La scultura è stata sbozzata dopo la rimozione dell’alburno e vuotata da tergo, nel tronco e nelle braccia, quando il legno era ancora fresco (lo si riconosce dalle creste sollevate sulla superficie) per ridurre la massa e limitare la formazione di spacchi radiali durante la stagionatura (presenti comunque in alcune zone).
La vuotatura del tronco è stata realizzata con attrezzi da sgrossatura con la lama perpendicolare al manico (piccole asce), leggermente curva (curvature diverse a seconda delle zone) e dal taglio di circa 20 mm; la vuotatura della testa è stata invece avviata alla sommità con un trapano manuale e poi proseguita con sgorbie dalla lama simile alle precedenti.
Il trapano è stato usato anche per l’apertura delle cavità degli incastri delle braccia, con successiva rimozione del legno, “strappato” con uno scalpello piatto.
La rifinitura del modellato è stata sicuramente eseguita dopo l’assemblaggio sulla croce. Si tratta di una consuetudine tecnica legata all’impossibilità di far combaciare, e quindi completare, l’intaglio dei vari elementi senza contiguità della superficie.
Pulitura del Cristo
Altra scelta fondamentale compiuta in corso di restauro è stata quella della pulitura, che ha cambiato profondamente l’immagine consueta.
La delicata operazione è stata discussa a lungo, e condivisa all’unanimità con il Comitato scientifico e il Comitato promotore, anche per il suo forte impatto dal punto di vista devozionale.
Mutare l’aspetto di un’opera come conseguenza del restauro è il risultato di solide acquisizioni scientifiche e di attente valutazioni conservative, da condividersi e comunicare correttamente.
Nello specifico del Volto Santo, l’incarnato e la veste di Cristo, ma anche la croce e il nimbo erano caratterizzati da una cromia superficiale scura, assunta a partire dal XVII secolo in maniera non uniforme nelle diverse parti. Era una stesura che offuscava la leggibilità del modellato e delle decorazioni, talvolta in maniera grossolana, come si vede in alcuni dettagli.
Tale strato superficiale scuro veniva probabilmente rinnovato negli anni. Le indagini scientifiche hanno rivelato la presenza di cera di paraffina, risalente quanto meno alla metà dell’Ottocento (perché è un derivato del petrolio), evidentemente stesa come protettivo.
Al di sotto di queste stesure, tuttavia, la pellicola pittorica appariva alle indagini e alle osservazioni al microscopio poco lacunosa e ben conservata.
Gli approfondimenti diagnostici, in particolare l’acquisizione dell’immagine in IR falso, le osservazioni al microscopio e i primi saggi di pulitura confermavano nella veste l’esistenza di uno strato pittorico di lapislazzuli di altissima qualità e in buono stato conservativo.
Per quanto riguarda l’incarnato, la pellicola pittorica era poco lacunosa e ben leggibile, pur con segni di consunzione da sfregamento e perdita delle velature, in particolare sul volto.
Dopo numerosi test, la pulitura ha quindi interessato la rimozione dello strato superficiale a cera pigmentata e della ridipintura più recente, nera sulla veste e color bruno scuro sugli incarnati.
Non è escluso che lo scurimento sia dipeso dal fumo delle candele e delle lampade presenti all’interno del tempietto e che l’immagine si sia modificata a poco a poco nel tempo. Lo suggerisce il fatto che sul retro della scultura vi sono tracce significative di nero fumo, che vanno dal basso verso l’alto. I perni di aggancio del corpo alla croce sono scuri solamente sul lato inferiore e a vista e ciò indica non solo che il fumo veniva dal basso, ma anche che quando è avvenuto il cambiamento cromatico la statua era agganciata alla croce. La cromia scura non compare all’interno della testa, probabilmente perché questa è particolarmente aggettante e quindi più protetta; qui, inoltre, doveva essere posizionata la cassetta reliquiario. Ulteriore indizio a favore di tale ipotesi, infine, è la punta del naso particolarmente scura nella parte inferiore più aggettante.

Pulitura della croce
Per quanto riguarda la croce, il cui legno, come detto, ha una cronologia analoga a quello con cui è realizzato il Cristo, la pulitura ha interessato lo strato superficiale scuro e i sottostanti strati di azzurrite assai lacunosi e in pessime condizioni di conservazione, che non consentivano alcun intervento di ricucitura per dare leggibilità al testo.
Era invece evidente, e conservata in maniera più estesa dell’azzurrite, gran parte della decorazione più antica, che si è riusciti a recuperare, lasciando a vista il legno nelle parti in cui il colore manca completamente.
Essa rivela la preziosa vivacità cromatica che ha caratterizzato l’insieme nei primi secoli di vita e le sezioni stratigrafiche mettono ben in evidenza la complessità della situazione dal punto di vista delle successioni degli strati pittorici. Una croce quindi nata assieme al Cristo (come rivelano la datazione del legno, la lavorazione continua dell’intaglio di spalle e capelli, la policromia che scontorna il corpo), che in origine era decorata nei toni del rosso e blu, rinnovata nel tempo, che ha assunto, a partire dagli inizi del Trecento, una cromia azzurra estesa a tutta la superficie, infine nascosta da uno strato scuro, come le altre parti dell’insieme.
La sua pulitura ci ha impegnato in lunghissimi ragionamenti, anche dal punto di vista metodologico. A questo riguardo desideriamo ricordare le competenze ed intuizioni di Marco Ciatti, che al Volto Santo ha dedicato tantissimo, anche negli ultimi giorni di vita: le sue osservazioni su questa specifica operazione sono state per noi illuminanti ed anticipatrici delle scelte effettuate.
Dorature
La pulitura della veste di Cristo si è limitata alla rimozione dello strato superficiale scuro e della ridipintura nera; quest’ultima si estendeva grossolanamente anche su parte della doratura. Sono così emerse in tutta la loro preziosità le decorazioni dorate del bordo delle maniche e del girocollo che prima non si vedevano.
Lo scollo della veste presenta una decorazione, forse quattrocentesca, a girali. Non si tratta di una tecnica a graffito, ma di una decorazione realizzata a pennello con colore nero, steso sopra la doratura, come si può evincere da un’attenta analisi al microscopio per la mancanza di colore all’interno della craquelure della foglia d’oro, nonché dalle indagini in Infrarosso-Falso Colore, che documentano la presenza di un materiale diverso dal lapislazzuli della veste.
Alcuni campioni stratigrafici mostrano che nel tempo la doratura della veste è stata ripetuta, utilizzando la medesima tecnica a foglie d’oro sovrapposte.
Come per la veste in lapislazzuli, è stato riportato alla luce solo lo strato più superficiale (la seconda doratura), assai ben conservato, preservando gli strati sottostanti.

Occhi
Nonostante gli occhi appaiano leggermente differenti l’uno dall’altro, il materiale con cui sono stati realizzati è simile: vetro bianco opaco e blu traslucido. Ciascun occhio è costituito da tre parti ottenute modellando del rottame di vetro di epoca romana (probabilmente tessere musive che le indagini diagnostiche datano a prima del V sec. d.C.), ridotto in graniglia e riportato allo stato plastico per rifusione. Le differenze nell’aspetto delle parti blu dei due occhi sono probabilmente attribuibili alla rifusione di miscugli leggermente diversi.
Il Settore di restauro Materiali ceramici, plastici e vitrei dell’OPD, utilizzando la tecnologia 3D, ha integrato la parte lacunosa della sclera dell’occhio sinistro, permettendo così di restituire allo sguardo la sua profonda espressività originaria.
Tessili
Il Settore restauro Materiali tessili è intervenuto nella cintura della veste, in particolare nella parte terminale, particolarmente deteriorata. Le frange, ormai ridotte in frammenti cortissimi, in passato arrivavano quasi a lambire la decorazione del bordo inferiore della veste.
Le indagini diagnostiche hanno svelato preziose informazioni sul materiale del filato, che risulta essere seta, e sul suo colore rosso acceso, derivato da una miscela corrispondente a quella menzionata nelle ricette medievali come color paonazzo.
Nimbo
Il grande Nimbo che circonda il Volto Santo (circa 240 cm di diametro) si compone di una struttura lignea ripartita in due archi di cerchio che si connettono alla sommità per mezzo di un elemento in ferro, utile anche per la sospensione.
Il fronte del Nimbo è rivestito di 14 lastre d’argento sbalzate e cesellate con cherubini entro nervature a rilievo dorate; le lastre sono tenute in posizione da 23 profili in rame dorato, fermati lungo i margini della struttura lignea da chiodi. Sulle lastre in argento sono fissate 384 gemme in pasta vitrea, alternate a gruppi di quattro di colore verde smeraldo e rosso rubino molto intensi, al cui centro è posto un fiore quadripetalo in argento.
Queste rosette dovrebbero essere quelle aggiunte dall’orefice Felice Frugoli nel 1838, quando presentò un “conto di lavoro per il cerchio che adorna la Sacra Effige del Volto Santo, per numero cento rosette di quattro pietre per cadauna incastrate in argento con sua vite e zermiera dietro alle dette”.
Alle estremità inferiori sono fissati due gigli in lamina di rame dorata.
L’opera era ricoperta da uno spesso strato di colore scuro identificata dalle indagini di laboratorio come una gomma vegetale alterata, applicata sulla superficie e debordante sulle paste vitree. La struttura lignea interna (databile al XV – prima metà del XVI secolo in base all’indagine di radiocarbonio) versa in buone condizioni, sostanzialmente integra e priva di significative manifestazioni di biodeterioramento.
Per quanto riguarda le lamine metalliche, erano presenti fenomeni di solfurazione e ossidazione dell’argento, con annerimento più o meno intenso del metallo; pochi i punti di lacerazione e i prodotti di corrosione legati all’interazione con l’umidità atmosferica.
Settori OPD coinvolti
Settore di restauro Scultura lignea policroma; Settore di restauro Materiali tessili; Settore di restauro Oreficerie; Settore di restauro Materiali ceramici, plastici e vitrei; Settore di restauro Dipinti su tela e tavola – Reparto Supporti lignei; Laboratorio scientifico e di Climatologia.
Opificio delle Pietre Dure
Soprintendente
Emanuela Daffra
Settore Sculture lignee policrome
Direttore: Sandra Rossi
Funzionari Restauratori: Rita Chiara de Felice (Direttore tecnico), Sara Bassi, Claudia Napoli
Settore Dipinti su tela e tavola – Reparto supporti lignei
Direttore: Sandra Rossi
Funzionario Restauratore: Luciano Ricciardi (Direttore tecnico)
Settore Oreficeria
Direttore: Riccardo Gennaioli
Funzionari Restauratori: Paolo Belluzzo, Cinzia Ortolani (Direttore tecnico)
Settore Materiali tessili
Direttore: Riccardo Gennaioli
Funzionari Restauratori: Guia Rossignoli (Direttore tecnico), Licia Triolo
Settore Materiali ceramici, plastici e vitrei
Direttore: Laura Speranza
Funzionari Restauratori: Chiara Fornari (Direttore tecnico), Shirin Afra, Chiara Gabbriellini
Settore Pitture murali
Direttore: Renata Pintus
Funzionari Restauratori: Sara Penoni (Direttore tecnico), Maria Rosa Lanfranchi
Laboratori scientifici
Direttori: Andrea Cagnini, Monica Galeotti, Simone Porcinai
Climatologia e conservazione preventiva
Direttore: Monica Galeotti
Assistente tecnico: Sandra Cassi
Laboratorio fotografico
Direttore: Simone Porcinai
Fotografi: Marco Brancatelli (Direttore tecnico), Giuseppe Zicarelli